
Nel libro di Nicolò Rubbi “Silenzio di bosco, rumore di sé”, la corsa come strumento di terapia.
Intervista di Anna Magli a Nicolò Rubbi, filosofo e giornalista.
Per alcune persone il silenzio è un lusso che non riescono a permettersi. Quando la sofferenza è forte, lo si cerca come uno spazio irraggiungibile ma forse sarebbe meglio ad accettare il proprio rumore e cercare di conoscerne la provenienza. Quando la terapia psicologica incontra uno sport di endurance, le due discipline si possono fare luce a vicenda. Perché non vi è differenza tra la sopportazione di un dolore fisico e di un dolore psicologico. Questa è una delle tante riflessioni che abbiamo trovato nel libro di Nicolò Rubbi, filosofo e giornalista, autore di Silenzio di bosco, rumore di sé. Correre per inventariare il dolore.
Lo abbiamo incontrato e cercato di capirne di più.
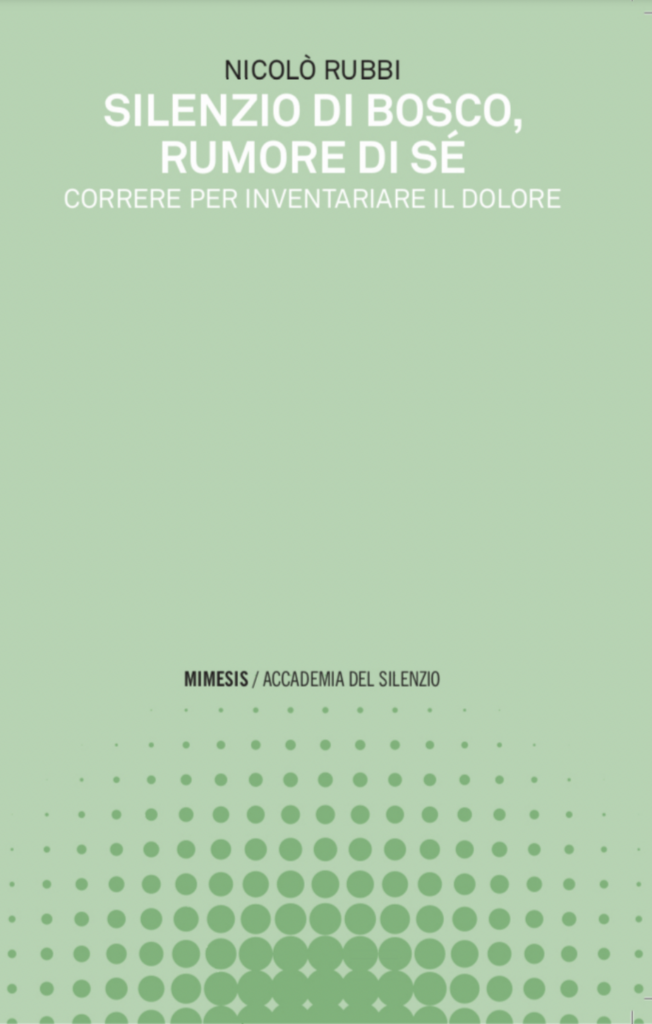
Nicolò quando è cominciata la tua attività di runner e come hai individuato il rapporto terapeutico tra attività fisica e il dolore?
Il mio amore per la corsa ha una storia giovane e un’origine oscura. Ho sempre praticato molto sport e a sedici anni ripetevo sempre che, se avessi dovuto correre, avrei potuto farlo solamente dietro a una palla o dietro a qualcuno. Mai correre per correre, dunque. E invece nel 2016 qualcosa è cambiato, qualcosa di cui non ho troppo insistito a cercare la fonte, la motivazione, il movente. Sentivo magneticamente che avrei dovuto prendere quella direzione, dismettendo la lunga pratica della Muay Thai e riprendendo in mano la passione più autentica, la montagna, di cui la corsa rappresenta solamente una modalità di approccio, una specifica forma d’amore vissuta col cuore su di giri. Poi c’è l’alpinismo, ma quella è un’altra storia. Va detto che la scelta della corsa coincise – ma non avevo intuìto subito la possibilità di una connessione tra le due – con la scoperta della bioenergetica, psicoterapia a base corporea. Quando Marco Di Giovanni mi mise nella ‘posizione della mondina’, per me insopportabile, e mi disse che non c’era alcuna differenza tra la sopportazione di un dolore fisico e di un dolore psicologico, ho avuto l’intuizione di poter utilizzare la corsa come strumento di terapia. I problemi di gestione delle energie nella lunga distanza di montagna mi sembravano somigliare molto a una metafora efficace per il trattamento di quanto in me irrisolto nella “strada lunga e tortuosa” – come cantavano i Beatles – dell’esistenza che avevo davanti. Non essendo uno di quei corridori capaci di andare più forte, e forse nemmeno uno di quelli capaci di procedere smodatamente oltre certi chilometraggi, ho deciso di inserirmi in quello sparuto gruppo di runners capaci di andarci più a fondo. Scriverne mi sarebbe riuscito senz’altro meglio che provare a improvvisarmi atleta potenzialmente vittorioso. Quello che cerco, tuttavia, non è mai il piacere masochistico del dolore, quanto unicamente la tregua della buona fatica, quel momento di quiete ormonale in cui si può mettere ordine ai pensieri e ricominciare un dialogo proficuo con la propria interiorità.
Nel tuo libro scrivi che “Non importa a quanto ammonti il chilometraggio, tutto si gioca sulla relazione del corridore con la distanza. E dal silenzio”. Cosa vuoi dire con questa affermazione?
Questo passaggio nasconde una tacita accusa alla nostra attualissima e occidentalissima inclinazione a misurare qualsiasi cosa, e a impostare giudizi di valore verso le persone sulla base di questa telemetria piuttosto fredda. L’assurdità che tutto sia calcolabile e controllabile attraverso un pugno di dati. Una volta un ragazzo mi chiese se vincevo le gare a cui partecipavo. Quando risposi che non c’era pericolo che questo accadesse, sbalordito mi domandò per quale motivo gareggiassi. Per moltissime persone è ancora la motivazione estrinseca a fare da motore della volontà; io, quando indosso le scarpette, mi sento piuttosto un vecchio guerriero Masai che cavalca al chiaro di luna o svolge la sua caccia senza alcuna garanzia di successo. Se proviamo a chiedere a un neofita della disciplina quanta fatica gli costi chiudere in corsa cinque chilometri di pista, capiamo come quell’anello sia per lei o per lui già una corsa di lunga distanza. Per un maratoneta, la mezza non è nulla; per una persona che copre al massimo una decina di chilometri, la mezza è un sogno che sembra impossibile. Per questo dico che la sfida non la fa il chilometraggio, ma la relazione che l’atleta intrattiene con esso. Inoltre, più la concentrazione del gesto viene sporcata dal pensiero, più la difficoltà si incrementa. Il professionista vorrebbe smettere di pensare per entrare nel flusso del movimento zen e centrare l’obiettivo, mentre qualcuno corre per riordinare le idee; qualcuno corre nel traffico, in mezzo ad altri podisti, mentre qualcun altro predilige la solitudine dei sentieri; qualcuno ascolta la musica, qualcuno interroga il proprio corpo o i rumori del bosco. Quindi mi viene da chiedere: cosa vogliamo sentire? Che la risposta sia tutto o nulla, il silenzio fa da protagonista o da sfondo. Io volevo sentire me stesso, anche se non mi piaceva granché quello che avevo da dirmi.
Che ruolo gioca il bosco in questa relazione? E quanto influisce la presenza di una selva invece che altro contesto naturale?
Nel libro descrivo il momento in cui, partecipando al primo trail, mi accorsi di poter andare oltre la distanza che avevo coperto fino ad allora in allenamento solo grazie al potere che il contesto del bosco esercitava su di me. Mi chiedo come si faccia a uscire dalla testa – ammesso che sia questo l’obiettivo – correndo in tondo. Vincere la circolarità del pensiero con la circolarità di un tracciato è geometricamente insensato. Bisogna rompere il cerchio, e i tracciati nei boschi aiutano in questo alimentando la corsa con una dose di bellezza. I giochi cromatici degli alberi, i profumi, il canto degli uccelli che si sovrappone al nostro respiro di recupero creano un’atmosfera di evasione, di apertura, dove lo sguardo torna attento sulle cose del mondo. Il privilegio di venire distratti. Ognuno corre con le modalità che predilige, ma chi tiene gli auricolari nel bosco mi ha sempre incuriosito. Il paesaggio non passa solamente attraverso la vista, e isolarsi come si farebbe in città rende il contesto boschivo totalmente neutro, identico a una ciclabile lungo i viali. Se i Metallica ci fanno compagnia in entrambi gli scenari, un posto vale l’altro. E poi mi sento di scomodare quella bellissima questione del verde, di quella ‘viriditas’ di cui scrisse così bene Il degarda di Bingen. Il potere del verde – verdità? verdezza? – è intrinsecamente terapeutico, sia per questioni di frequenze cerebrali e spettro cromatico, sia per la meraviglia che suscita questo teatro naturale capace di risvegliare in noi qualcosa di originario, sopito ma presente. Adesso che vivo nelle valli selvagge del Piemonte Orientale, correre è diventato letteralmente correre coi lupi. Ho realizzato il sogno di entrare in contatto col selvatico che dorme in me attraverso quanto di selvatico ancora vive nel mondo.
Tu scrivi che “L’ansia è un’amante fedele di moltissime persone. Non con tutti parla lo stesso linguaggio”, secondo i tuoi studi di psicoterapia quali sono i diversi linguaggi dell’ansia e come cambiano da persona a persona?
Prima di tutto, propongo di dissociare l’ansia dal suo connotato clinico più o meno preciso, pensandola piuttosto come quello stato di allerta che ci sembra una “risposta specifica dell’organismo” – così da manuale – di cui non riusciamo a cogliere l’aspetto specifico. Col tempo ho imparato a vedere nell’ansia la validazione della mia unicità, dal momento che i miei meccanismi di attivazione, le ragioni della mia allerta, i miei labirinti, incastri e sintomi non coincidevano e non coincidono con quelli di nessun altro, e questo vale per tutti. Ci deve rassicurare il fatto che essa sia un sentire comune, ma dobbiamo vivere con curiosità il tentativo di delineare il profilo della nostra. Percepisco ansia per situazioni che lascerebbero totalmente indifferente un’altra persona, e viceversa. Dunque io funziono così, io sono questo qui e non un altro; allora, invece che soffocare il sintomo, lo interrogo dandogli dignità di messaggio preciso. L’ansia – dal mio punto di vista – è lo statuto dell’unicità di ciascuno. Inoltre, questa singolarità di percezione ansiosa in qualche modo ci libera dalle catene di un’omologazione anche psicologica, che ci vorrebbe tutti residenti in quell’oasi di quiete situata potenzialmente alla fine di un cammino di terapia. A mio parere, una delle più belle definizioni di psicoterapia la diede Carl Gustav Jung, quando la descrisse come la gestione che ciascuno fa dei propri deserti. La psicoterapia mi ha insegnato, da paziente e da studioso, a gestire la mia ansia con un atteggiamento di accoglienza curiosa. Quando arriva, mi mette in allerta; mi chiede di mettere in discussione la quiete di poco prima: perché non dovremmo intendere tutto questo disagio come un’occasione per osservare con occhio critico ciò che diamo per scontato? Non saprei proprio elencare i sintomi degli altri, però esternamente riesco a leggere nei momenti ansiosi di amici e famigliari un codice che è loro e soltanto loro. Posso dire, in base a ciò che ho osservato, che l’ansia si serve del potenziale di ciascuno: essendo io uomo di linguaggio, l’ansia si trasforma in una cascata di parole interiori contrarie, scomode, intrusive; persone più corporee somatizzano ben di più perché è il corpo il luogo in cui si distingue ed eccelle il loro sentire; persone emotive erompono in collere e pianti che sembrano ingiustificati, eppure è il disagio che si serve del loro punto di forza per portare alla luce la propria debolezza.
La tua psicoterapeuta ha individuato il superamento del tuo stato di ansia con un lavoro da svolgere su due piani: un dialogo mente-mente e un dialogo mente-corpo. Molte persone arrivano istintivamente a questa soluzione. Come si può spiegare la validità di questo approccio?
Ho sempre trovato significativo che, nel mezzo di un percorso di studi che mi aveva reso estremamente concettuale, io incontrassi Francesca e la sua psicoterapia biosistemica. Quando compresi che avrei orientato i miei sforzi intellettuali successivi in direzione della psicologia, trovai persino Marco e la bioenergetica. Era come se la mia parte più selvatica – da sempre la chiamo così e non conosco un termine più valido – reclamasse il suo spazio mettendomi sul cammino psicoterapeuti che avevano a che fare con quell’aspetto della mia persona e della mia personalità che era rimasto più indietro. Dialogo mente-mente e dialogo mente-corpo sono sostanzialmente due modi complementari per trattare il materiale energetico di cui siamo fatti, sia esso conscio o inconscio. La prima ha radici profonde quanto i rituali sciamanici di propiziazione delle parti interne, le cui modalità sono oggi confermate – anche se declinate col linguaggio e gli strumenti della scienza – dagli studi sulla frammentazione del sé e dalla relativa possibilità di integrare le parti entrandovi in dialogo. La seconda è antica quanto lo è il nostro sistema di espressione corporea, e si serve di quei canali naturali (sessualità, movimento, gioco, vocalità) che ci permettono di mettere la mani in pasta con il correlato fisico dei vissuti traumatici da un punto di attacco diretto e sensibile. Muovere il corpo porta a galla vissuti inscritti nell’armatura caratteriale, come scrisse Alexander Lowen. Ogni volta che imbocco una salita e porto il corpo a una condizione di stress prima sconosciuta, il pianto bussa alla porta e mi accompagna per i primi chilometri, per poi sparire. Quando entro nel corpo sottile, invece, con esercizi bioenergetici da fermo, incontro più spesso la rabbia della tristezza. Quanto stanato dal corpo può venire così negoziato col dialogo.
Il tuo libro si conclude con una frase che sembra quasi una sconfitta. “Sono sceso a patti con molte cose, correndo. Una su tutte: quel silenzio che ho tanto cercato come simbolo della mia quiete, in me non esiste, o forse non esiste per nessuno. Possiamo invece dire che è solo il risultato di un lungo percorso?
Sconfitta è una parola carica di un valore che mi riporta alla logica della prestazione. Se proprio vogliamo mantenere la dicotomia vittoria/fallimento, questa frase conclusiva intende semplicemente dire che non ho vinto secondo la modalità con cui pensavo di doverlo o poterlo fare. Però si tratta di un passo successivo: sono proprio uscito da questa logica, e ho preferito comprendere, capire, e stare con quello che c’era. Vincere significava anche per il me di allora un’operazione di bonifica generale in direzione del benessere più pieno e più statico. Sono sceso a patti nel senso che ho imparato a lasciarmi attraversare da quello che sentivo e a conferire eguale dignità a tutti gli stati interni. In questo la metafora del bosco mi è servita: senza erbacce, aghi di pino essiccati, tronchi marcescenti, fauna che percorre la selva libera e incontrollata e innocua, una foresta sarebbe piuttosto un giardino. Il bosco mi ha insegnato a mantenere incolta una parte di me, e la cedevolezza – antitetica alla cieca forza, alla resistenza, all’eroico furore sui miei stati d’animo – è il riconoscimento del lato in ombra della mia persona. Questo penso si intraveda tra le pagine di “Silenzio di bosco”, e in questo sta il punto di contatto col lettore. Una volta qualcuno mi disse che il titolo suonava depressivo e, appunto, arreso. Ma personalmente mi chiedo cosa ci sia di più autenticamente coraggioso che fermarsi, girarsi, e mettersi a guardare pezzo per pezzo se stessi, fronteggiando quanto di più scomodo e imponderabile vi si possa trovare al fondo. “Inventariare” non è soccombere ai propri detriti, quando piuttosto imparare a stare quietamente seduti sulle proprie macerie e pianificare nuovi progetti. Inventariare è il termine cui sono più affezionato, una sorta di acme del mio percorso, che conoscerà senz’altro, ancora molti picchi e ancora molte valli. Non progredisce forse nel lutto per la perdita di una persona amata chi si fa forza e apre i cassetti di casa per riordinarne le fotografie?
